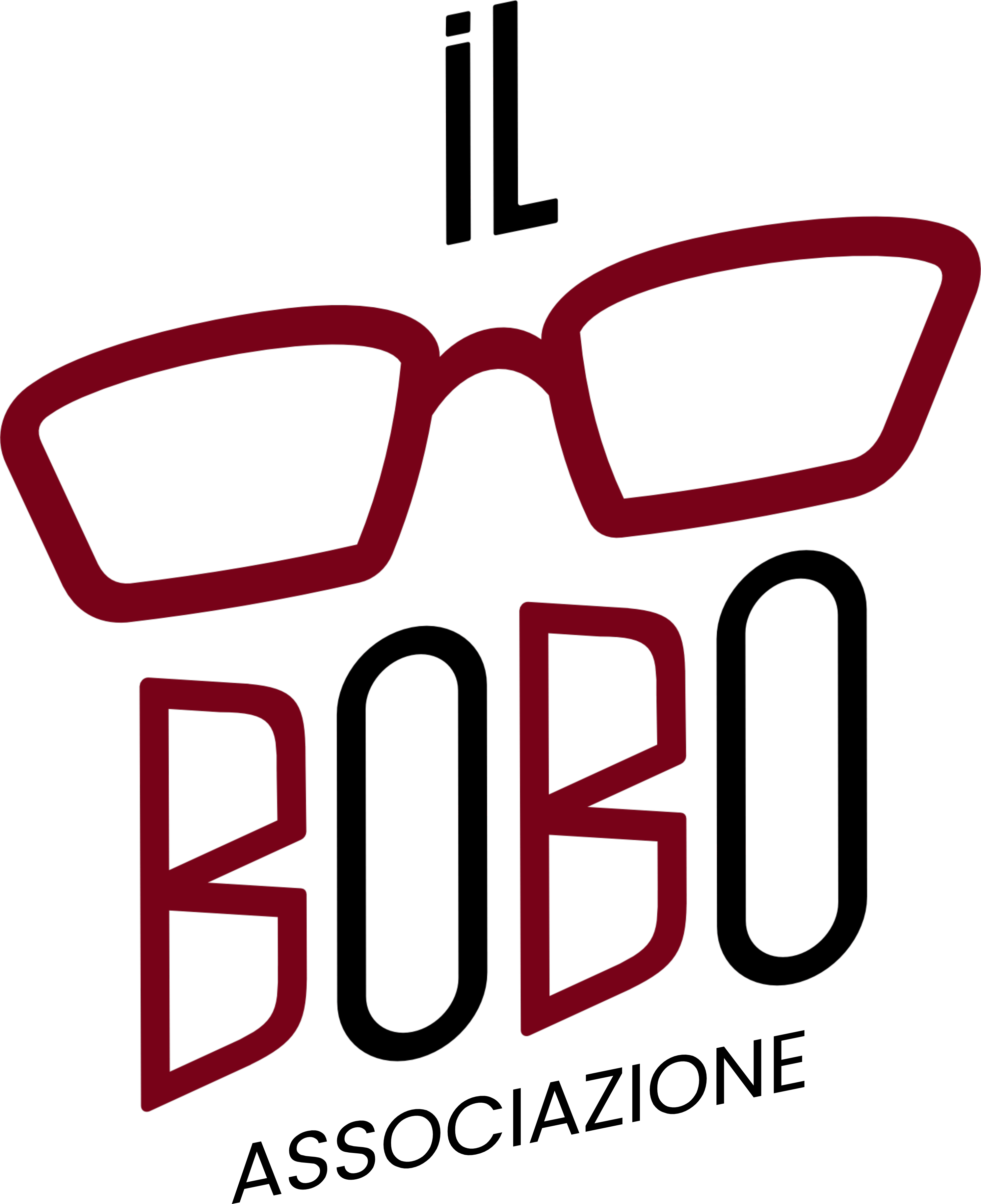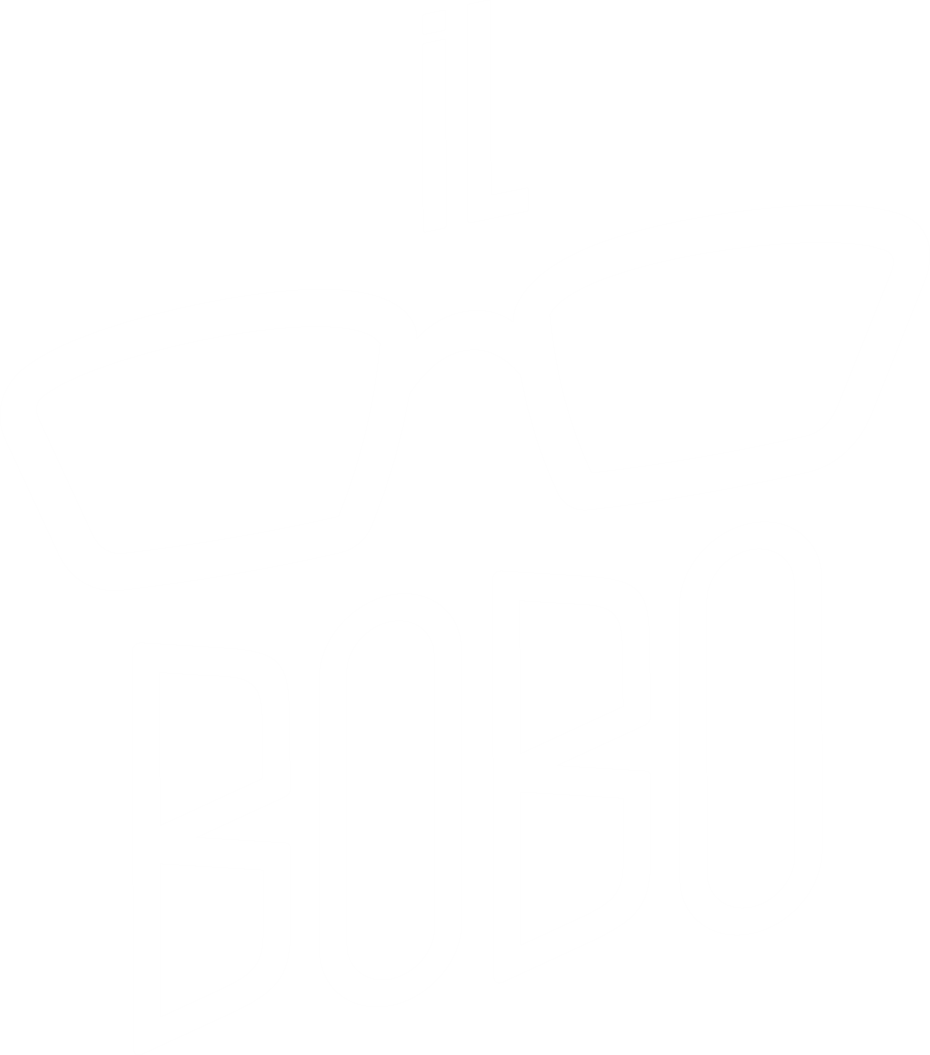Il modello sudtirolese come strumento per la pace in Ucraina
Ai tempi della guerra russo-georgiana dell’estate del 2008, che interessò le due regioni di confine dell’Abcasia e dell’Ossezia, venni invitato dal Magnifico Rettore dell’Università di Tblisi a tenere un seminario sullo Statuto di autonomia speciale del Sud Tirolo.
Ricordo che ne parlai a lungo anche con Bobo: eravamo d’accordo sull’eccezionale potenziale diplomatico dello strumento autonomista, specialmente nei casi dei conflitti territoriali.
Nei territori di frontiera è infatti molto facile che si scatenino quelli che un esponente della tradizione etico-civile sudtirolese, Claus Gatterer (1924-1984), di formazione liberale e attento alle questioni delle minoranze, definì gli «irredentismi antagonisti», a causa della pervicace azione dei nazionalismi contrapposti. In questo ambito, spicca – per contenuti autonomisti e forza pacificatrice, garantita dagli accordi internazionali, a cominciare dall’accordo De Gasperi-Gruber negoziato a Parigi il 5 settembre 1946, a margine della Conferenza di Pace – lo Statuto di autonomia sudtirolese.
Non è un caso che l’applicazione dello statuto speciale del Sud Tirolo nasca dalla necessità di bilanciare istanze contrapposte all’indomani di eventi bellici. Si tratta di un vero e proprio punto di sutura nelle profonde ferite della Storia, capace di emanciparsi dalle ragioni della forza, per affondare le proprie radici nella “forza della ragione”, che da sempre coincide con il principio di autodeterminazione delle comunità locali. Uno strumento valido ancora oggi, tanto da essere più volte invocato anche per risolvere la crisi Ucraina, fin dagli accordi di Minsk del 2014/2015. Purtroppo, il fallimento di quella tregua non ha portato i frutti sperati, ma ciò non deve farci dimenticare come la tradizione diplomatica italiana possa offrire soluzioni di pace non solo sul piano dei principi, ma soprattutto nella concreta applicazione statutaria istituzionale.
Nel caso dell’Ucraina è bene riepilogare come, a partire dal 2006, l’instabilità e le crescenti tensioni interne abbiano indotto le forze politiche a governare nel nome dell’unità nazionale. Ma nel nome di quale senso di unità e identità? Si tratta infatti di un’identità nazionale ucraina quanto meno sfilacciata, per effetto dell’eterogenea e variegata composizione del tessuto sociale dal punto di vista etnico, culturale e linguistico. Nel territorio dell’attuale Repubblica di Kiev convivono infatti ucraini, russi, rumeni e moldavi, bielorussi, tatari, bulgari, ungheresi, polacchi, armeni, greci e altre minoranze. Davanti a un così articolato mosaico sarebbe un errore fatale ridurre l’identità nazionale ucraina alla sola antitesi del “non essere russi”. Una vera prospettiva di pace può fondarsi soltanto con il superamento della mentalità della guerra e con l’affermazione positiva di ciò che si è. Per farlo il principio cardine è nel diritto di autodeterminazione dei popoli. L’autodeterminazione è riconducibile all’alveo dei diritti naturali di una comunità volontaria territoriale. È quindi un diritto pre-politico, che viene prima e sta al di sopra dello Stato. È indisponibile dallo Stato poiché rientra tra i diritti fondamentali dell’uomo e, dunque, della comunità territoriale. Si tratta di un diritto che riconosce a una Comunità la prerogativa di scegliere liberamente – come diceva Miglio – di «stare con chi si vuole e con chi ci vuole», per essere totalmente padroni di se stessi e determinare autonomamente il proprio destino.
E tuttavia del diritto all’autodeterminazione dei popoli – riconosciuto formalmente nell’Atto finale di Helsinki nel 1975 – non è possibile né ammissibile farne un uso disinvolto. A suo tempo venne riconosciuta l’autodeterminazione perché l’obiettivo era quello di minare alla radice i sistemi politici dell’Europa centro-orientale. Riconoscendo il diritto all’autodeterminazione dei popoli furono create le condizioni affinché nascessero tutti quei movimenti politici riconducibili al più vasto fenomeno del dissenso, come Solidarność in Polonia e Charta 77 in Ceco-Slovacchia; fenomeno che si è imposto come l’elemento più importante e incisivo tra le molteplici cause che hanno portato, nel 1989, alla caduta del muro di Berlino.
La strada maestra che potrebbe percorrere oggi l’Ucraina è rappresentata dall’adozione di un modello di autonomismo, da riconoscere alle comunità volontarie territoriali che sono state coinvolte da un conflitto più che decennale, in modo da vincolare la fine delle ostilità affermando la sovranità dei territori. Occorre un modello di autogoverno dai tratti coraggiosi, ispirato a quello adottato nei confronti del Sud Tirolo. Uno Statuto speciale, quello sudtirolese, che viene ammirato e studiato come modello per i territori multietnici e multiculturali di tutto il mondo. Basta leggere l’articolo della columnist Celestine Bohlen dal titolo Italy’s Historic Multicultural Compromise, apparso sul “New York Times”, il 24 marzo 2014, oltre a ricordarsi dell’articolo 11 dei citati accordi di Minsk del 2014-2015, in cui si auspicava una riforma costituzionale, in Ucraina, basata sul principio di decentramento politico e amministrativo e l’adozione di uno statuto «speciale» per le regioni di Donetsk e Lugansk.
Una rivoluzione pacifica che si concretizza a partire dalle parole con cui gli ordinamenti si auto-definiscono, a partire dal superamento – come accade in Svizzera – dell’aggettivo «nazionale» a favore di «confederale», per sottolineare la peculiarità di quel modello, ma anche la natura dell’obbligazione e della delega nel quadro della lealtà pattizia dei contraenti dell’accordo che regge lo Stato. Solo così è possibile formalizzare compiutamente il principio dell’autonomia istituzionale e politica, legislativa e amministrativa dei territori.
Questo riconoscimento di una piena autonomia statutaria supplirebbe peraltro a una clamorosa negligenza compiuta dalle istituzioni sovranazionali nel momento in cui si sciolse l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Tra le Repubbliche baltiche, la Bielorussia e l’Ucraina – da Murmansk a Sebastopoli, per intenderci – non venne individuata una fascia di realtà geopolitiche «cuscinetto» tra l’area di influenza americana, cioè della Nato, con la Russia. E questa considerazione oggettiva e realistica alimenta le inquietudini – e anche la legittimità storica – degli «irredentismi antagonisti». Nel nome del tempo che fu.